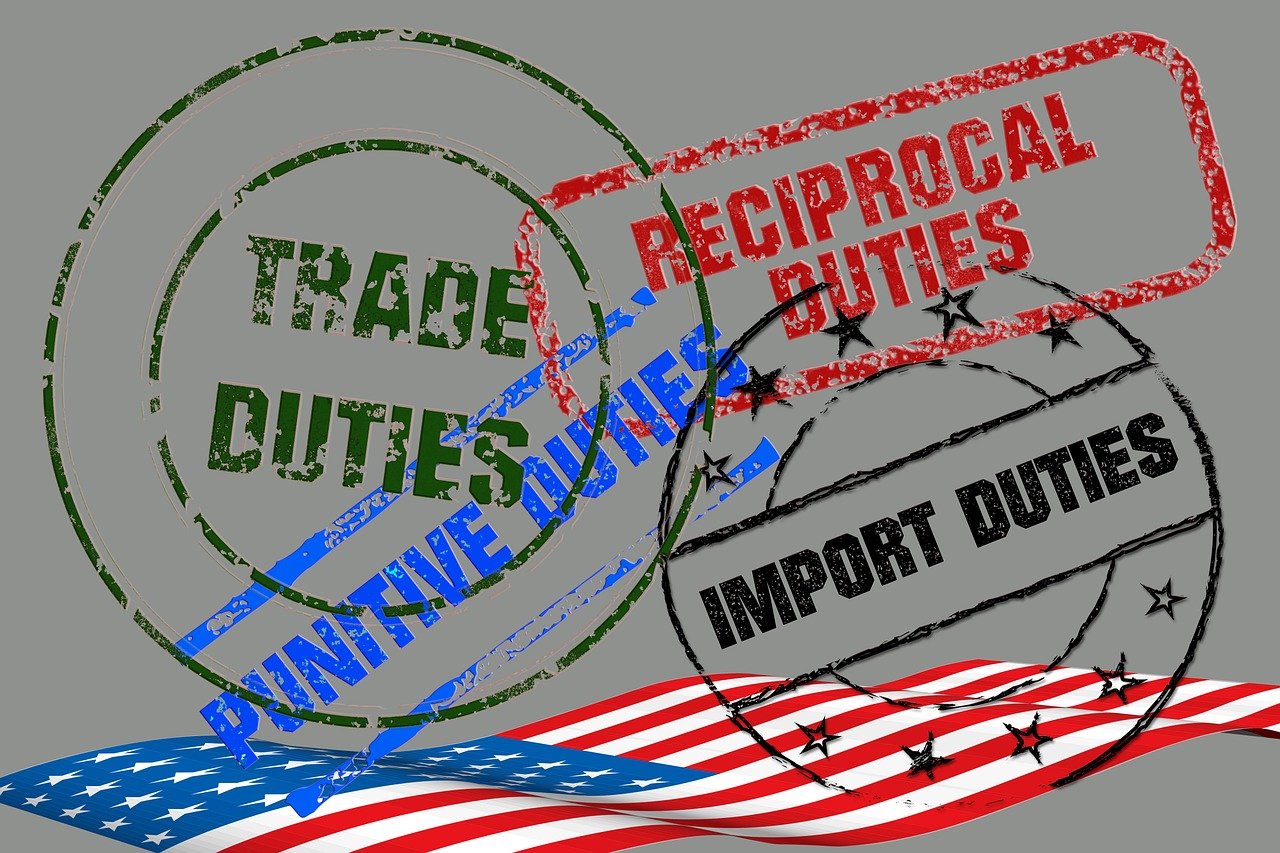
Catastrofisti contro ottimisti. C’è chi lo ritiene un totale fallimento, come gli esponenti delle opposizioni in Italia, e chi, al contrario, lo vede come “il meglio che potevamo ottenere”, come ha affermato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.
L’accordo con il presidente americano, Donald Trump, sui dazi del 15 per cento è ovviamente un compromesso, tra l’altro dai contorni sfumati. E come tale si presta ad interpretazioni diverse. Intrise anche di un bel po’ di propaganda.
Nonostante qualche centro studi si sia affrettato a vaticinare con esattezza le perdite per i singoli comparti produttivi, fare previsioni è quantomai difficile. Del resto chi potrà dire con certezza quanti cittadini statunitensi continueranno ad acquistare il Parmigiano Reggiano o la mozzarella di bufala, nonostante i rincari?
Ci permettiamo, quindi, di fare due osservazioni generali sull’accordo.
La prima: è chiaro che a chi fa seriamente impresa i dazi non possono mai piacere. Costituiscono un privilegio a senso unico (tutto da dimostrare, però, in quanto gli americani pagheranno di più i prodotti), in antitesi con quel libero mercato che ha permesso a tante nazioni di raggiungere il benessere e di incrementarlo – la Cina è soltanto l’ultimo esempio. Quindi, va detto forte, i dazi costituiscono un problema.
È altrettanto vero, però, che è difficile contrastare la strategia protezionistica del presidente Trump, essendo alla guida del più grande colosso produttivo al mondo. Il tycoon è soprattutto un abile affarista e sa bene che per chiunque è arduo – se non impossibile – rinunciare ai servizi statunitensi, si pensi soltanto alle nuove tecnologie o alle armi. L’impegno comunitario ad acquistare il gas liquefatto e il petrolio dagli americani per 750 miliardi di dollari in tre anni conferma una sudditanza che ha radici antiche.
Non a caso l’intesa con l’Unione europea ha in comune un’amara verità con gli altri accordi tra Usa e Paesi di tutto il mondo: i dazi sono più alti per tutti. Se prima di Trump il dazio medio effettivo degli Stati Uniti era attorno al 2-3 per cento, oggi viaggia intorno al 15-20 per cento. E a poco sono servite le differenti strategie adottate dai contraenti, dalle contromisure e dai controdazi fino al dialogo. Dal Canada al Messico, dal Brasile alla Cina, dal Regno Unito al Vietnam, dal Giappone fino all’Unione europea i risultati non sono granché differenti tra loro.
Insomma, si poteva ottenere di più? Forse, ma non è facile fare la voce grossa con la principale potenza mondiale, che rappresenta tra l’altro uno dei primari mercati di sbocco per le esportazioni dei Paesi europei. E vanno evidenziate le endemiche fratture all’interno dell’Unione europea, confermate anche in questa complicata trattativa: Francia e Spagna, meno esposte commercialmente con gli Usa, avrebbero voluto il bracco di ferro a differenza di Italia e Germania, che esportano soprattutto oltreoceano.
Una seconda osservazione sull’accordo Usa-Ue riguarda la scelta del male minore. L’intesa con gli Usa, non va dimenticato, assicura la continuità degli scambi economici, evitando una guerra commerciale – con dazi ad almeno il 30 per cento – dalle infauste conseguenze. L’escalation avrebbe di fatto paralizzato l’export e creato disorientamento e sconcerto nei mercati. Un monito a chi critica l’accordo senza aver valutato i costi dell’alternativa.
Certo, le nostre esportazioni comunque ne risentiranno, per quanto sia difficile fare previsioni. Così anche i posti di lavoro. I rincari delle merci – dall’alimentare alla moda, dalla meccanica alla metallurgia – saranno inevitabili, benché distribuiti nell’intera filiera: la principale preoccupazione è quella di lasciare spazio a forniture più convenienti per quanto, come sottolinea a più riprese in queste ore il ministro Lollobrigida, “alcuni prodotti nostri non sono replicabili negli Stati Uniti”.
Nel solo agroalimentare gli Usa costituiscono il nostro secondo mercato di sbocco con quasi otto miliardi di euro di vendite, l’11,4 per cento dell’export totale, dietro la sola Germania e davanti alla Francia. Il vino è la voce che pesa di più e per la quale ci sono i maggiori timori, come ricorda Giacomo Bartolommei, presidente del Consorzio Brunello.
Ultima annotazione: ai dazi occorre aggiungere l’effetto della svalutazione del dollaro, intorno al 15 per certo. Ciò equivale a vendere negli Usa con prezzi più alti del 30 per cento. Non poco.
Siamo certi che tutto ciò comporterà nuovi equilibri. Con la politica che deve fare la sua parte. Per accrescere la competitività delle nostre aziende deve supportare principalmente incentivi in digitalizzazione e in ricerca e sviluppo.
 UNSIC – Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori
UNSIC – Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori
